Dal Nomos al Caos: come Carl Schmitt aveva previsto l’Era di Trump
8 Novembre 2025 pubblicato in Libri
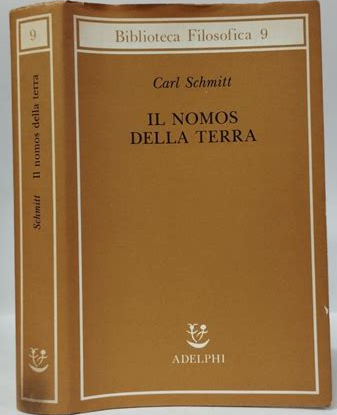
Esiste un momento preciso nella storia del pensiero giuridico occidentale in cui la guerra smise di essere un fatto politico per trasformarsi in questione morale. Fu quando il nemico, da avversario riconosciuto e legittimo, divenne criminale da processare. Da quel momento il conflitto perse ogni argine, limite e possibilità di pacificazione reale. L’inimicizia si fece assoluta e la violenza illimitata, mascherata dietro nobili parole: giustizia, umanità, democrazia. Carl Schmitt identificò questa cesura con lucidità implacabile nella sua opera del 1938, Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff (La svolta verso il concetto discriminatorio di guerra), approfondendola poi nel capolavoro del 1950, Il Nomos della terra nel diritto internazionale dello Jus Publicum Europaeum. A oltre settant’anni di distanza, mentre l’Occidente si confronta con Russia, Iran e Cina non come potenze rivali ma come incarnazioni del Male, la profezia schmittiana si rivela nella sua fattuale concretezza.
Lo Jus Publicum Europaeum: l’età dell’equilibrio
Per comprendere radicalità ed attualità della critica schmittiana occorre risalire al cuore della sua riflessione storico-giuridica: l’idea di nomos. Questo termine greco, derivato da némein (dividere, distribuire, pascolare), indica per Schmitt l’atto originario con cui un popolo prende possesso della terra, la misura, la delimita e la organizza. Significativamente, per i Romani, la Limitatio (delimitazione del confine) era l’atto giuridico di fondazione che seguiva la consacrazione della terra agli Dei (Conditio); e in definitiva ogni altro ordinamento giuridico tradizionale è nato da una presa concreta dello spazio, dato che il diritto non è astrazione normativa ma radicamento territoriale. Ogni nuova presa di terra, secondo Schmitt, comporta un nuovo ordine spaziale, “un nuovo nomos”. Dopo le Grandi scoperte geografiche e la dissoluzione dell’unità cristiana medievale, l’Europa creò un nuovo nomos globale: lo Jus Publicum Europaeum, sistema giuridico che disciplinò le relazioni internazionali dal Trattato di Westfalia (1648) fino alla Prima guerra mondiale. Fu un’epoca straordinaria. Per la prima volta nella storia, la guerra venne sottratta al giudizio teologico e morale e ricondotta a fatto giuridico regolato. Il cardine di questo sistema era il concetto di justus hostis, il “nemico giusto”. Il justus hostis è il nemico riconosciuto come legittimo: uno Stato sovrano che combatte un altro Stato sovrano con eserciti regolari e in base a un conflitto politico delimitato nello spazio e nel tempo. Non incideva tanto chi avesse ragione o torto sul piano morale: la guerra era formalmente legittima se condotta tra soggetti riconosciuti dal diritto internazionale del tempo. Il concetto di justus hostis è un capolavoro della ragione umana. Esso permetteva di distinguere nettamente tra guerra e pace, tra combattenti e civili, tra Europa (dove vigevano regole) e spazi coloniali (dove tutto era lecito). Oltretutto, rendeva possibile la neutralità: uno scontro tra due potenze non trascinava automaticamente l’intera Europa nel vortice bellico.
La criminalizzazione del nemico
Questo equilibrio si spezzò definitivamente con il Primo conflitto mondiale. Schmitt individua la svolta nel momento in cui gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Woodrow Wilson, trasformarono il conflitto da guerra europea tra Stati sovrani in crociata morale per “rendere il mondo sicuro per la democrazia”. Da quel momento la guerra tornò ad essere discriminatoria: non più scontro tra eguali, ma lotta contro un nemico ingiusto, criminale, da annientare. Superato dunque il concetto di justus hostis, riemerge quale nemico da annientare il pirata, ovvero, più modernamente, il gangster. Il nemico non è più un avversario politico con cui è possibile trattare o fare pace, ma un volgare bandito da processare. Gli sconfitti vengono ridotti al rango di “criminali di guerra” e privati di ogni legittimità politica. La Germania fu per due volte doloroso esempio di questa logica: Versailles 1919 non fu una pace, ma una sentenza di condanna morale che gettò i semi del secondo conflitto mondiale. I successivi processi di Norimberga e Tokio a carico dei responsabili politici e militari di Germania e Giappone (l’Italia, come è noto, passò dalla parte dei vincitori nel settembre 1943 e regolò sbrigativamente i conti a Piazzale Loreto), sancirono l’istituzionalizzazione della guerra moralizzata, con la conseguente affermazione della giustizia penale del vincitore quale strumento di legittimazione della pace. La conseguenza di questa trasformazione è intuibile: se il nemico non è più un justus hostis ma un’incarnazione pro-tempore del Male, allora ogni freno cade e la guerra si trasforma in un conflitto totale senza confini né regole tradizionali. In nome dell’umanità, della democrazia e dei diritti umani si giustifica la violenza più spietata, perché – come aveva ammonito Schmitt – dietro la retorica umanitaria si cela una definitiva logica di annientamento: i valori più elevati non ammettono limiti, e così lo ius in bello (l’antico e codificato diritto dello stato di guerra) perde ogni vincolo regolamentato, spalancando le porte a scontri privi di freno. Questo trasformismo moralistico travolge anche la neutralità degli Stati terzi, esigendo da ciascuno una scelta, e polarizza l’intero sistema internazionale, rendendo impossibile ogni efficace mediazione.
Il presente come ritorno del passato
Ed eccoci all’oggi. Quando osserviamo il conflitto tra Occidente collettivo (Stati Uniti, Unione Europea, NATO) e le potenze che esso definisce “autoritarie”, “autocratiche” o “terroriste” – di volta in volta Russia, Iran, Cina, Libia, Serbia, Siria, Palestina, Venezuela – riconosciamo nitidamente l’applicazione dello schema schmittiano della guerra discriminatoria. Questi Stati non sono riconosciuti come soggetti sovrani con legittimi interessi geopolitici da negoziare, ma vengono moralizzati come minacce esistenziali all’ordine liberale, incarnazioni del Male da contenere o eliminare. La retorica dominante non parla di conflitto di interessi, di sfere d’influenza, di equilibri di potenza. Parla di “aggressione non provocata”, di “Stati canaglia” e “dittatori criminali”, di “difesa della democrazia contro l’autocrazia”. Riemerge l’antico concetto religioso di guerra giusta, che non a caso oggi sublima nel belato di appelli all’ossimorica “pace giusta per l’Ucraina”. Vladimir Putin viene bollato come “criminale di guerra”, l’Iran come “regime teocratico oppressore”, la Cina come “minaccia sistemica”. Non si tratta più di Stati con cui trattare, ma di nemici da delegittimare, isolare e prima o poi rovesciare. Le sanzioni totali, la chiusura dei canali diplomatici, l’esclusione dagli organismi internazionali e persino dalle competizioni sportive, la criminalizzazione mediatica: tutto questo richiama la logica che Schmitt aveva denunciato come preludio alla guerra civile globale. Paradossalmente, questa moralizzazione della politica internazionale avviene sempre in nome della pace e dei diritti umani. E così la “responsabilità di proteggere” diventa giustificativo per Hiroshima, Gaza e il diluvio di bombardamenti “umanitari”; le sanzioni economiche (che affamano intere popolazioni civili) vengono motivate come “difesa dei valori”; l’espansione della NATO viene presentata come “libera scelta democratica” e non come accerchiamento strategico.
Il vuoto del nomos
Schmitt aveva lucidamente previsto che la dissoluzione dello Jus Publicum Europaeum non avrebbe portato alla pace perpetua kantiana, ma al caos. Senza un nuovo nomos condiviso, senza un ordine spaziale riconosciuto da tutte le potenze, il mondo scivola inesorabilmente verso uno stato di conflittualità permanente. La grande questione è dunque l’urgenza di un nuovo nomos della terra che supplisca ai terribili sviluppi della dissoluzione dello Jus Publicum Europaeum. E tuttavia il nuovo nomos non può nascere dall’imposizione unilaterale di un modello universalistico. L’Occidente pretende di essere il legislatore morale dell’umanità, ma questa sua pretesa – oltretutto viziata da una chiara indole suprematista – è precisamente ciò che impedisce la formazione di un autentico e stabile equilibrio internazionale. Un nuovo nomos richiederebbe, al contrario, il riconoscimento reciproco tra grandi spazi di civiltà, il rispetto delle sfere d’influenza in una prospettiva multipolare, la rinuncia alla crociata ideologica ed all’imperialismo culturale. Richiederebbe, in altre parole, il ritorno al principio del justus hostis: riconoscere il nemico come controparte legittima, non come criminale da annientare.
Oltre il moralismo
La lezione di Schmitt è scomoda, persino scandalosa per la pruriginosa sensibilità dell’occidentale contemporaneo, ebbro di narcisismo morale. Obbliga a guardare in faccia una verità che molti preferirebbero ignorare: la politica internazionale non è il regno del Bene, ma quello della forza e dell’equilibrio. Pretendere di trasformarla in tribunale etico significa solo mascherare degli interessi particolari dietro ipocrite retoriche universalistiche che rendono i conflitti più feroci e interminabili. Questo non significa cinismo, né tantomeno giustificazione della violenza. Significa piuttosto accettare che la pace non nasca dalla vittoria definitiva del presunto Bene sul fatidico Male, ma dal reciproco riconoscimento tra avversari che, in spirito di realismo politico ed autoconservazione fisica, accettano di gestire il conflitto, limitandone portata materiale e durata nel tempo. Significa capire che la guerra può essere contenuta solo se resta guerra, cioè scontro regolato tra Stati sovrani, e non degenera in crociata apocalittica, oltretutto a rischio termonucleare. Nel mondo attuale, dominato dalla retorica dei “valori occidentali” contro le “autocrazie”, la voce di Schmitt risuona come monito profetico. Quando si nega al nemico la qualità di justus hostis, quando lo si criminalizza e demonizza, quando si dichiara di combattere non per interessi ma per l’Umanità ed al contempo si vietano per legge Diplomazia e buon senso, allora la lotta perde ogni limite. E ciò che si presenta come difesa della civiltà diventa, per paradosso, il viatico per una nuova, lunga fase di regresso e dilagante barbarie.
Giovanni Moscato

